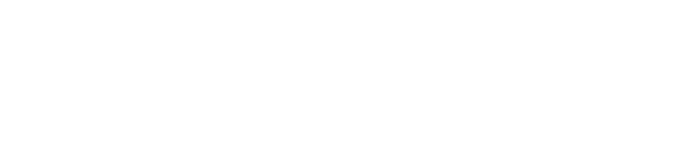Andrea Bruzzichelli: Le “3C” di sangue dell’Amazzonia occidentale
Il nostro amico Andrea Bruzzichelli ci ha inviato una interessante nota sulla storia recente (mai abbastanza conosciuta) dell’Amazzonia occidentale, che pubblichiamo volentieri, trattandosi di riflessioni su derivate da esperienze personali di un nostro concittadino, di grande attualità.
Le “3 C” di sangue dell’Amazzonia occidentale
… E veramente ve ne sarebbe una quarta, quella di “Cristianesimo”: dato però che i fatti umani devono essere storicizzati – cioè contestualizzati nella cornice dell’epoca e della cultura nella quale si sono verificati, non valutati con la mentalità corrente – parlarne servirebbe solo ad alimentare polemiche vuote e, appunto, antistoriche. D’altra parte è noto che, anche superati i tempi tristissimi dell’Inquisizione, l’integralismo di certi missionari – sia protestanti che cattolici – ha continuato a provocare l’annichilimento delle culture native e violenze: anche un nostro quasi conterraneo, Fra’ Giuseppe Illuminato Coppi da Abbadia San Salvatore, arrivò con il suo atteggiamento a provocare nell’area una rivolta in tempi non lontanissimi (1883). Tempi fortunatamente cambiati, almeno per i missionari cattolici.
Ma è di fatti meno noti, almeno i primi due, che si vuole parlare.
La prima “C” decorre grosso modo fra il 1860 ed il 1930 – con un breve ritorno nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in conseguenza dell’invasione giapponese del Sud-Est Asiatico – e sta per caucciù (cioè “l’albero che piange”), la gomma naturale che si estrae – mediante intagli sulla corteccia – dall’Hevea Brasiliensis ed alberi di specie consimili, richiestissima man mano che lo sviluppo industriale ne andava scoprendo le enormi possibilità d’impiego. Nella foresta amazzonica le piante non stanno raggruppate per specie come nei nostri boschi: qui i castagni, là i lecci… L’immensa varietà delle specie è invece sparpagliata sul territorio e due alberi dello stesso genere distano chilometri l’uno dall’altro. Se a ciò si aggiunge che il prezioso lattice appena goccia dalle incisioni praticate sul tronco, addotte in un piccolo recipiente, si può ben comprendere quanto laboriosa e difficile ne fosse la raccolta per arrivare a disporre di grandi quantità.
Poche potentissime famiglie – per lo più colombiane e peruviane, ma non solo – variamente appoggiate dalle autorità locali (ma i loro agganci arrivavano fino a quelle federali: l’anteprima dei Cartelli dei narcos), si divisero il business per decenni. Tristemente noti furono gli Arana, peruviani, ma gli altri non furono da meno: indigeni schiavizzati e migliaia di disgraziati, attratti dal miraggio di un lavoro, vennero impiegati nella foresta (non un boschetto: un territorio vasto oltre 20 volte l’Italia…). Costretti a riportare quotidianamente agli accampamenti quantità di lattice che imponevano di raggiungere ogni giorno un certo numero di alberi, dovevano ripagare alla “amministrazione” (si parla dei bianchi, perché gli indigeni non erano nemmeno considerati ed erano falcidiati anche dalle mille nostre malattie) tutto ciò che ricevevano – cibo, vestiario, attrezzi – con il prodotto delle loro fatiche: un debito del quale non riuscivano mai a venire a capo. Né era loro consentito andarsene: gli sgherri dei “datori di lavoro” non solo li angariavano negli accampamenti, nei quali erano padroni assoluti, ma sorvegliavano i corsi d’acqua – uniche vie per evadere da quella immensa prigione verde priva di sbarre – ed eliminavano senza pietà chi ci provava e più in generale chiunque tentasse di ribellarsi; o semplicemente chi gli pareva. Alla morte di tanti uomini – uccisi dai loro aguzzini e dalla foresta – si aggiunse quella di tante donne, portate a “servire” nei campi dei raccoglitori. Impossibile stimare quante siano state le vittime del caucciù: hanno finito per nutrire la selva almeno due centinaia di migliaia di corpi.
In quegli anni fiorì la capitale dell’Amazzonia, Manaus: dotata anche di un monumentale teatro dell’opera – decorato con stucchi in foglia d’oro, ispirato alla Scala e realizzato con l’ampia partecipazione di tecnici, artisti e materiali italiani; reso celebre dal film Fitzcarraldo – nel quale arrivavano ad esibirsi dall’Europa (ovviamente strapagate) le più famose orchestre e compagnie dell’epoca. La città era il ritrovo dei “Colonnelli” (i possidenti) e dei loro capoccia, nonché delle loro costosissime amanti. Poi tutto finì di colpo com’era cominciato: i semi del prezioso albero erano stati trafugati all’estero, cosa vietata sotto pena di morte, e ne vennero create ordinate e ben accessibili piantagioni soprattutto in Indocina. Quando il caucciù cominciò ad esservi prodotto su larga scala, quello amazzonico non interessò più a nessuno. Manaus rischiò di scomparire, per riprendersi solo negli anni ’60 del secolo appena trascorso: dotata di un grande aeroporto e costituita in “zona franca”, è da ormai cinquant’anni la capitale industriale del bacino amazzonico: oggi che la gomma è sintetica, vi si producono DVD e computer.
Alberto Vàzquez-Fìgueroa, autore di romanzi famosi tradottisi in film di successo come Ashanti (dallo scritto Ebano), ne ha dedicato uno anche a questo argomento: Manaos, pure finito sul grande schermo con la sua personale regia e attori come Fabio Testi e Florinda Bolkan.
La seconda “C” prese avvio più o meno nello stesso periodo e raggiunse il picco nel primo trentennio del ‘900 (ma non si è ancora spenta del tutto): sta per Cacciatori di Teste.
Alcuni popoli del bacino amazzonico – in particolare i Jivaros – usavano decapitare i più temibili guerrieri nemici che riuscivano a vincere in guerra e ne riportavano le teste. Non sempre e non come trofeo: per le loro credenze, lo spirito alberga nel cervello e quello del nemico vinto poteva tornare a perseguitarli dal Mondo dei Morti. Per questa ragione avevano luogo cerimonie sacre particolari e, con un procedimento assai complesso, le teste – ridotte a circa un terzo del volume normale, pur mantenendo un qualche tratto riconoscibile del defunto – si riteneva potessero imprigionarlo, impedendogli di nuocere. Questo sembrava necessario solo per qualche tempo, poi della tsantsa (così vengono chiamate le teste trattate) ci si poteva disfare.
Quando i “civili” bianchi si imbatterono nelle tsantsas, scatenarono la corsa all’oro. Svilupparono con esse un incredibile e macabro (morboso) commercio, alimentato in tutti i modi possibili: dalla costituzione di bande di assassini che procuravano la “materia prima”, al furto di cadaveri dagli obitori, fino al tentativo di realizzare tsantsas con teste di scimmie…. Nessuno è sfuggito a quella febbre: non solo privati collezionisti, ma praticamente tutti i musei etnografici del mondo hanno le loro tsantsas; strapagate, anche se la larga maggioranza è stimata essere falsa, cioè frutto della “corsa” e non delle originarie lotte tribali, oltre che maldestramente preparata. Da considerare che per i nativi la spinta al collaborazionismo aveva origine diversa dalla sete di ricchezza: non interessati al denaro, e per la verità a ben poco di quanto i bianchi potessero offrire, per un certo periodo potettero ottenere qualcosa di utile o desiderato (per esempio un fucile per cacciare o un buon coltello) solo procurando in cambio un certo numero di tsantsas…
Dato il genere di fenomeno, il numero complessivo delle vittime di esso – comunque incalcolabile – non è certo comparabile con quello della prima “C”: ma diverse migliaia di innocenti hanno fatto certamente le spese dell’immondo commercio. Ricordato è un fatto avvenuto nel 1919, allorchè un gruppo di turisti in visita a Quito (Ecuador) si vide offrire una tsantsa ed alcuni oggetti di proprietà del malcapitato: da essi risultò trattarsi dell’antropologo svedese naturalizzato USA Markus Lindstrom, professore presso l’Università di Chicago, scomparso senza lasciare tracce 6 anni prima in piena Amazzonia nel corso di una spedizione scientifica…Pare che ancora oggi si trovino “collezionisti” disposti a pagare una piccola fortuna per una tsantsa (vi sono annunci anche su Internet): vero che i Romani dicevano De gustibus non est disputandum, ma francamente…
Anche i potentissimi Incas nutrivano un … sacro rispetto per i bellicosi popoli della foresta, che non tolleravano intrusioni nel proprio territorio, e pare fosse questo uno dei motivi per i quali preferivano costruire le strade di accesso alle loro città e santuari posti sulle Ande, ma al limitare della selva (che vi si abbarbica fin quasi a 3.000 metri di altitudine ed è la più selvaggia e impenetrabile del bacino amazzonico), sulle creste anziché nei fondovalle. Come noto, gli Incas continuarono a lungo a resistere agli Spagnoli dopo la conquista del proprio impero: in particolare, quello che è considerato l’ultimo Inca – Tùpac Amaru, che ha dato il nome anche ad un famoso movimento guerrigliero, i Tupamaros – dette loro molto filo da torcere. Perduta l’antica capitale, Cusco, ne aveva realizzata un’altra proprio al riparo della foresta: Vilcabamba. Tale città (con il suo inevitabile corteggio di storie di tesori favolosi) è stata oggetto di innumerevoli spedizioni di ricerca ed è stata via via ravvisata in vari centri ritrovati da esploratori ed archeologi: la stessa piccola Machu Picchu venne inizialmente presa per essa nel 1911 dal suo scopritore, Hiram Bingham, che stava in effetti cercando la città perduta e che forse l’aveva trovata senza riconoscerla, sepolta com’era nella vegetazione. Solo una dozzina di anni fa Vilcabamba di Espiritu Pampa pare essere stata identificata con l’antica capitale: i resti sono imponenti, la certezza … è altra cosa.
La prima volta che sono stato in Perù – verso la fine degli anni ’70 – erano in corso al riguardo diverse spedizioni: avvalendosi della ricognizione aerea, tentavano di raggiungere ogni “qualcosa” che pareva nascondere ruderi e che veniva avvistato (o che pareva di avvistare…); qualche pazzo arrivava addirittura a farsi paracadutare nei pressi, per evitare il difficilissimo avvicinamento via terra. Bene: correva voce del ritrovamento dell’accampamento di una spedizione scomparsa due o tre anni prima, cosa che – non so in base a quale “evidenza” – veniva imputata ai Cacciatori di Teste … Viene da chiedersi, a quali ?
Certo è che, ammesso e non concesso che qualche popolo nativo sia ancora sfuggito al contatto con la “civiltà”, non può che trovarsi in quell’area dell’Amazzonia: dove la foresta pluviale si infila con i suoi tentacoli ed il labirinto dei suoi vorticosi corsi d’acqua in mezzo alle pareti a picco della Cordigliera Andina.
La terza “C” è ben nota, purtroppo: sta per coca.
Nota da sempre sia ai popoli andini che a quelli della foresta, la masticazione della foglia serve a lenire fame, sete, fatica e – per coloro che vivono o si spostano a grande altezza (le Ande superano i 6.000 metri) – il freddo e il cosiddetto “mal di montagna”. Piccole borse di tessuto destinate a portare con sé le foglie sono state rinvenute fin negli scavi archeologici delle necropoli delle popolazioni più antiche e fin sulle sponde del Pacifico; è tipica una specie di bolla che si forma all’angolo della bocca di quelle popolazioni che per tutta la vita ricorrono a quel (per loro, prezioso) aiuto, qualcosa di analogo a quanto accade per la nicotina a denti e labbra nei fumatori accaniti. E ancora oggi, atterrando a Cusco (m. 3.400 slm) dopo un volo abbastanza breve da Lima (m. 50 slm) al turista è consigliato di starsene una ventina di minuti seduto, appena arrivato in albergo, e gli viene offerta una tazza di tisana fatta con foglie di coca: è rimedio immediato per quanto lo sbalzo di altitudine potrebbe provocare e che richiederebbe altrimenti tempi ben più lunghi di adattamento.
L’uso da parte dei popoli della foresta è parzialmente diverso: oltre che utilizzate al naturale, le foglie vengono tostate e impastate con foglie sfarinate di varie piante per formare palline da tenere in un angolo della bocca per qualche ora durante cerimonie sacre. A seconda di ciò che lo sciamano – sacerdote e guaritore – vi aggiunge (estratti vegetali e animali, di alcuni funghi, ecc., contenenti alcaloidi), possono avere qualche effetto allucinogeno: serve – dicono – per uscire da sé, vedere da fuori (dall’alto), capire meglio e di più, scoprire i pericoli che li minacciano… Tutto ciò è strettamente funzionale alla cerimonia – che si svolge in comunità, in genere riservata rigorosamente ai maschi e che abbiano compiuto i 10/12 anni (usciti quindi dalla tutela materna) – dura lo spazio di una notte, si ripete molto raramente, non induce alcun genere didipendenza né presenta aspetti “strani”: solo musica, danze e canti.
Questa sorta di preparato sacro è chiamato ipadu ed il nome è rimasto anche quando il tutto ha cambiato profondamente … fisionomia; ancora una volta grazie ai bianchi ed alla loro inesauribile sete di denaro, da un lato, ed al desiderio smodato di “sballo” – in assenza di bisogni veri e vita dura – dall’altro.
Nel corso degli anni ’60 del secolo scorso (guerra in Viet-Nam) viene scoperta la risorsa “coca”, o meglio la sua versione da laboratorio, la cocaina. La responsabilità è nordamericana, degli stessi che oggi lottano contro i Cartelli e per cancellare le piantagioni: la Storia si fa spesso beffe degli uomini… Grandi quantità di foglie vengono tostate o essiccate e trattate chimicamente (nel processo vengono impiegate varie sostanze: dalla calce al cherosene, all’ammoniaca…) e la “pasta” viene poi “tagliata” per moltiplicare i guadagni: in ciò la fantasia dei chimici può sbizzarrirsi, visto che praticamente qualsiasi cosa che vi possa essere mischiata per aumentarne il volume senza alterarne l’aspetto va bene, non importa di chesi tratta e quale l’effetto dell’intruglio.
Incalcolabile il numero delle morti dovute alla cocaina, considerato che la piaga alimenta anche la grande maggioranza di altre tipologie di fenomeni: dai drammi familiari e dalla criminalità spicciola, fino alla realizzazione di attentati ed alla destabilizzazione di Governi e Paesi, all’intrecciarsi con altro genere di traffici. Il business è enorme e non c’è la concreta volontà di stroncarlo: mentre nelle aree di produzione vengono combattute vere e proprie guerre contro e fra i Cartelli, con vittime e sofferenze infinite per le popolazioni, nei Paesi di sbocco si lotta sì contro il narcotraffico, ma “a metà”: ipocritamente non si colpiscono i consumatori che lo alimentano; neppure,per esempio,cominciando ad escluderli dalle varie branche della pubblica amministrazione edalle candidature/cariche politiche. Così tutto continua: in America del Sud circola la voce che anche molti dei grandi (per noi) quantitativi di droga sequestrati dalle varie polizie qua e là per il mondo vengano a volte fatti intercettare dai Cartelli stessi, facendo filtrare volontariamente informazioni, perché l’eco della notizia incide sul prezzo nel mercato finale locale …
La fine della terza “C” non è all’orizzonte. Quella della foresta amazzonica sì.
Andrea Bruzzichelli
Nota biblio-sitografica
L’Autore ci ha gentilmente inviato una integrazione sulle possibilità di approfondimento:
www.osservatoriodiritti.it “Droga: produttori di coca del Perù fra trafficanti e polizia” di Marta Gatti – 14.11.2017
www.unilibro.it – Amazzonia Libri (vasto catalogo di opere su quell’area)
www.viagginellastoria.it – “Una spedizione fra i Jivaros dell’Alta Amazzonia” di E. Bertarelli, 1940
Leonardo.it – “Arana – Il Re della gomma”
G. Illuminato Coppi – “Appunti interessanti del Missionario Apostolico francescano nell’America del Sud” – Tip. Arcivescovile S. Bernardino, Siena 1897
Università di Cagliari – Dottorato di Ricerca Studi Filologici e Letterari – Ciclo XXVI – “Tradizione orale, letteratura e violenza nell’Amazzonia peruviana: l’epoca del ‘caucho’ ” – di Stefano Pau – A.A. 2013/2014 (leggibile in rete)
Molte relazioni di Ermanno Stradelli sono state pubblicate (oltre che all’estero) nel “Bollettino della Società Geografica Italiana” fra il 1888 ed il 1896.