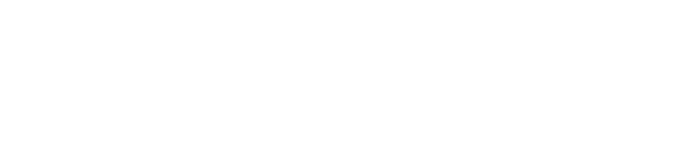News
Ci lascia il prof. Guido Alpa, amico e collaboratore della nostra biblioteca archivio
La Biblioteca Archivio Piero Calamandrei, istituzione del Comune di Montepulciano, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Guido Alpa. Grande avvocato e giurista, attento studioso del diritto inteso come strumento al servizio dei cittadini, maestro e divulgatore dei valori della Costituzione, lo abbiamo avuto vicino e protagonista nella valorizzazione del nostro archivio, con la mostra del Consiglio nazionale forense del 2013 durante la sua presidenza e la cura di pubblicazioni di inediti di Piero Calamandrei, dalla conferenza Fede nel diritto al contributi alla riforma del Codice di procedura civile, alla promozione della digitalizzazione delle Opere giuridiche insieme alla fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, di cui era illustre consigliere.
La Presidente, Silvia Calamandrei
PRESENTAZIONE EVENTO del libro di Ilaria Patamia “C’era ‘n ber sole. Storia di Settimia Spizzichino”, Editore People 2024
In una Roma indolente e bellissima, le sorelle Settimia e Gentile raccontano la propria storia dopo la razzia del quartiere ebraico di Roma del 16 ottobre 1943. Mentre Gentile, che si è salvata dal rastrellamento, attende a casa il ritorno delle donne della propria famiglia all’indomani della Liberazione, del tutto ignara della sorta toccata loro, Settimia, l’unica sopravvissuta, nel rientrare ripercorre gli eventi che l’hanno travolta, in un viaggio anche metaforico di andata e ritorno dall’inferno. “C’era ‘n ber sole” è la storia degli ultimi momenti di queste due donne, prima del loro ritrovarsi dopo quasi due anni. Due monologhi che si intrecciano come un dialogo a distanza, fatto di considerazioni e ricordi, in cui l’elemento tragico è filo conduttore del vissuto sia di chi ha patito le atrocità dei campi sia di chi ne è scampato, pur non credendosi degno della salvezza.
RECENSIONE. Giuseppe Filippetta, La repubblica senza stato, L’esilio della Costituzione e le origini della strategia della tensione
Giuseppe Filippetta, La repubblica senza stato, L’esilio della Costituzione e le origini della strategia della tensione, Feltrinelli 2024
Il saggio di Filippetta, denso e stimolante, ricostruisce la storia italiana dalla Costituente in poi attraverso il contrappunto tra principi costituzionali elaborati con forte impronta dossettiana, azionista e socialcomunista e l’apparato statale che dovrebbe metterli in opera ed invece li lascia inapplicati o addirittura li contrasta. Uno Stato che non applica la sua Costituzione e fa di tutto per lasciarla lettera morta.
Si parte dalla strage di Portella della ginestra del 1947 in contemporanea con l’affermazione alla Costituente da parte di Moro ed altri dossettiani di ambiziosi progetti di coinvolgimento delle masse popolari nello Stato, nonché con gli attacchi al latifondo delle riforme Gullo e poi Segni per mostrare come in Sicilia l’alleanza tra grande proprietà agraria, mafia, Chiesa e DC di Scelba si muova in senso opposto a contrastare ogni progetto riformistico. Forse la prima strage di Stato, all’alba della Repubblica, con depistaggi e falsificazioni mai chiarite fino in fondo.
Insomma la Repubblica è segnata fin dalla nascita da questa dicotomia tra Stato apparato che sviluppa anche articolazioni operative segrete in un connubio tra polizia, ministero degli interni, servizi segreti e collegamenti internazionali in funzione anticomunista: la Guerra fredda spinge al recupero anche degli eredi del fascismo e al loro riciclaggio.
Si descrive quindi come la ricostruzione dà il via libera al liberismo padronale nella repubblica “fondata sul lavoro”, contrastando e reprimendo l’anelito di autogestione e le esperienze di democrazia in fabbrica nate nella Resistenza.
La ricostruzione del paese, finanziata dal piano Marshall e sfruttata dal grande padronato, manda in esilio la Costituzione e si consolida con la politica repressiva scelbiana, i licenziamenti punitivi in fabbrica e i reparti speciali, le stragi come quella di Modena. I dossettiani sono emarginati nella DC e De Gasperi gestisce un’alleanza atlantista che trova nella Chiesa supporto ideologico nella battaglia anticomunista.
Filippetta attinge agli archivi, ai dibattiti parlamentari, alla stampa d’epoca, alla letteratura, ma anche ai documentari e film girati da registi come De Santis e Lizzani per documentare la resistenza operaia e contadina nelle fabbriche, nelle manifestazioni e negli scioperi, così come nelle roccaforti di solidarietà dal basso, soprattutto in Emilia Romagna: c’è un’altra Italia che cerca di affermare i principi sanciti della Costituzione che l’apparato statale ignora e disattende e trova forme di lotta come gli scioperi alla rovescia per affermare il diritto al lavoro, il diritto alla libera espressione, il diritto di sciopero.
Filippetta colloca la vera svolta sul crinale tra anni sessanta e settanta, con lo svilupparsi di grandi movimenti di massa che portano all’attuazione di una serie di riforme che inverano parti della Costituzione, dalle Regioni, al diritto di famiglia, al diritto allo studio, alla sanità, allo Statuto dei lavoratori. Ma di fronte a questi sviluppi lo Stato apparato si difende e sviluppa strategie eversive utilizzando il suo strumentario clandestino, contrastando la nascita di una democrazia partecipata che persegue la giustizia sociale.
Vittima di questo scontro è lo stesso Aldo Moro, la cui figura apre e chiude il volume.
Il 13 marzo 1947, alla Costituente, Moro parla di Resistenza, di rivoluzione, di democrazia integrale, di liberazione dell’uomo. Sostiene che la Resistenza è stata un’esperienza rivoluzionaria “non tanto perché si indirizza a sostituire sistemi economici superati, ma perché rappresenta l’ascesa irresistibile verso posizioni di responsabilità consentanee alla dignità umana di coloro che troppo a lungo furono esclusi dall’esercizio di un potere, il quale pur disponeva totalmente della loro sorte”.
Un’idea di “Repubblica emancipatrice” che gli sembra in via di realizzazione con il conflitto pluralistico esploso con il 68 e l’autunno caldo. In un discorso del ’69 ed in tanti altri dei primi anni Settanta citati da Filippetta, Moro indica nella Costituzione il faro attorno a cui legare insieme istituzioni, partiti e cittadini.
Filippetta coglie l’isolamento e la perspicacia di Moro, che saranno anche la sua condanna. La strategia morotea dell’attenzione al Pci prima e della solidarietà nazionale poi non sarebbe una “semplice intesa tra i partiti, ma coinvolgimento del Pci nella prospettiva del rafforzamento della democrazia italiana attraverso l’accoglimento delle richieste di partecipazione e di giustizia che salgono dalla società”.
La parte conclusiva del saggio è dedicata proprio al sequestro Moro, alle ambiguità di comportamento dello Stato apparato e dei brigatisti e al suo esito tragico, che pone fine al progetto di rinnovamento della democrazia italiana:
“Una fine che è un ritorno, il ritorno dell’egemonia privatista e dell’assolutezza del comando del capitale sul lavoro [citazione da Tronti]. La società “è rimessa al suo posto”, ne sono spente le dinamicità progressive e le aspirazioni di giustizia, tanto che scompare il tema dell’attuazione della Costituzione repubblicana, definitivamente sostituito da quello della riforma costituzionale e dell’efficienza del Governo”.
La Costituzione, conclude Filippetta, non solo resta in esilio, ma viene bollata come ostacolo alla “governabilità”.
Si apre la stagione dei ripetuti tentativi di modificare e accantonare i principi della Costituzione per puntare sull’efficienza dello Stato apparato. Ed è una stagione che stiamo ancora vivendo.
[Silvia Calamandrei]
“Cosimo I & Giorgio Vasari a Montepulciano”
“Cosimo I & Giorgio Vasari a Montepulciano”
Celebrazioni poliziane per i 450 anni della morte di due straordinari personaggi del Rinascimento Italiano.
Venerdì 8 novembre 2024 alle ore 11:00 – Sala Bozzini, del Palazzo del Capitano, Piazza Grande, Montepulciano
Due percorsi espositivi presso il Museo Civico Pinacoteca Crociani e la Biblioteca Comunale e Archivio Storico P.Calamandrei per rendere omaggio due personalità che hanno segnato la storia della Toscana.
Interventi di:
Lara Pieri – Assessora alla Cultura e Istruzione
Francesca Cenni – Direttrice della Biblioteca Comunale
Patrizia La Porta – Direttrice del Museo
Duccio Pasqui e Riccardo Pizzinelli della Società Storica Poliziana
Letture a cura della Compagnia Teatro Impluvium.
L’evento è realizzato con il contributo della Regione Toscana, in occasione dei 450 anni dalla morte di Cosimo I de’ Medici e di Giorgio Vasari.
Intervento di Silvia Calamandrei presso Casadeipensieri FestUnità Bologna, 30 agosto 2024
Bologna 30 agosto 2024
Marco Polo e il suo ponte: un ricordo del 1955
Vi ringrazio di avermi invitata a presentare il mio libro Attraverso lo specchio, Cina andate e ritorni, una memoria privata della mia relazione con la Cina. L’invito avviene nel contesto della rievocazione del personaggio di Marco Polo., un personaggio di cui si celebra il 700mo centenario e che ha una forte valenza simbolica nel tratteggiare una relazione tra Italia e Cina aperta alla conoscenza reciproca e alla collaborazione.
Non a caso quest’anno è oggetto di esposizioni e convegni in Italia e in Cina, spunto per colloqui diplomatici e d’affari che si tenta di ricucire e rilanciare dopo la pausa del COVID e il ripudio dell’accordo sulla via della Seta che Xi Jinping era riuscito a stringere con Conte nel 2019.
La diffusione della pandemia impedì di dare luogo alle celebrazioni del 50mo delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, pur inaugurate in pompa magna a Roma dai due ministri della cultura. Per me fu l’occasione per una riflessione più intima della mia personale relazione con la Cina, aiutata anche dal ritrovamento fortunoso di un diario di me bambina a Pechino. Ma fu anche l’occasione di un progetto insieme all’italianista Yanglin, colpita dai racconti di scrittori italiani, Fortini e Cassola, che avevano visitato la Cina insieme a Piero Calamandrei nel lontano 1955. Avremmo editato in Italia e in Cina antologie di quel numero speciale del Ponte del 1956, che raccoglieva le testimonianze di quel viaggio.
Ora Marco Polo ha riofferto lo spunto di scambi, come lo offrì già alla fine degli anni 70, all’epoca della politica di apertura e riforme inaugurata da Deng Xiaoping, per accogliere una troupe cinematografica italiana, quella di Giuliano Montaldo, nella città proibita di Pechino e darle accesso agli sterminati territori percorsi dal veneziano per girare una serie televisiva sul viaggiatore italiano. Serie di grande successo in più di quaranta paesi, con le musiche di Morricone, che in questo 2024 è stata ritrasmessa in Cina e si può rivedere su Raiplay, esempio di una collaborazione in campo cinematografico che avrebbe prodotto altri capolavori famosi, e di scambi incoraggiati anche dal lavoro di Marco Muller, direttore di festival nei due paesi.
In un anno contrassegnato da foschi venti di guerra, in Europa e in Medio oriente, evocare un viaggiatore che percorre in pace un lunghissimo percorso tra Europa ed Asia grazie alla pax mongolica che l’impero fondato da Gengis Khan riuscì per un certo tempo a garantire è quasi paradossale.
La narrazione di Marco Polo, una sorta di Rough Guide del XIII secolo, divulgata soprattutto oralmente e nelle tante copie manoscritte tradotte in Occidente, fino ad ispirare Colombo nella versione spagnola (ben più del suo postero Galilei, checché ne dica il nostro Ministro della cultura) è stata conosciuta relativamente tardi in Cina, soprattutto attraverso le versioni ottocentesche in inglese. Le traduzioni cinesi risalgono alla fine dell’Impero, tra fine Ottocento e primo Novecento, in una fase di esplorazione della cultura occidentale che vede anche la traduzione dell’altra fondamentale opera trecentesca italiana, la Divina Commedia, il resoconto di un viaggio nell’ al di là di spessore interiore, che offre una geopolitica dell’immaginario contemporanea al pragmatismo descrittivo del mercante veneziano.
Per noi occidentali quel ponte di Marco Polo che varca il fiume Yong Ding, opera straordinaria di ingegneria e architettura in pietra che colpì il viaggiatore veneziano è anche il luogo dell’incidente che scatenò la guerra sino-giapponese del 1937, antefatto della nascita della nuova Cina nel 1949. Per i cinesi, è ora monumento nazionale: in verità il ponte odierno non è più quello descrittoci da Marco Polo, ma venne ricostruito all’epoca dell’imperatore Kangxi della dinastia dei Qing nel 1698, dopo che una inondazione lo aveva distrutto. La pietra e le statue dei leoni ne ricordano e conservano per taluni tratti la forma originaria.
Permettetemi ora di evocare una dimensione più personale , che è affrontata nel mio libro, risalendo al 1955, quando il personaggio di Marco Polo, che poco conoscevo da bimba italiana che frequentava la scuola cinese a Pechino, fa irruzione simbolicamente in duplice veste, in un incrocio familiare che vede mio nonno Piero a capo di una delegazione culturale in Cina e mio padre e mia madre, corrispondenti dell’Unità in viaggio in Tibet con un gruppo di giornalisti stranieri per incontrare il giovanissimo Dalai Lama, ancora presente a Lhasa.
Per pubblicizzare quelle corrispondenze l’Unità fece un manifesto in cui la foto di mio padre era affiancata a quella di Marco Polo e a quella di Giuseppe Tucci per sottolineare che l’inviato dell’Unità era giunto “sul tetto del mondo”.
A sua volta Piero Calamandrei visitò il Ponte di Marco Polo insieme alla moglie Ada, mentre il resto della delegazione aveva già raggiunto Shanghai. Non era una tappa della visita ufficiale; rimasti bloccati a Pechino per problemi di salute di Piero, la gita venne organizzata a livello individuale, e le fotografie del Ponte ritraggono la meraviglia e l’emozione della coppia, accompagnata dall’interprete Hongxing.
Piero annota nel suo diario di viaggio il 14 ottobre:
Al Ponte di Marco Polo. Andiamo coll’interprete: traffico contadino carretto trascinato da ciuchi, piccoli cavalli, piccoli buoi. Un cammello. Moltissime biciclette pedicab. Circa 15 chilometri. Sul ponte: al di là per fare la fotografia delle arcate, passo tra noccioline del Brasile distese in terra. In capo al ponte venditori di kaki. Ada conta i leoni, tutti differenti e decorati da medaglia. I leoni colla palla sotto la zampa, le leonesse coi piccoli. Un uomo che passa col carretto e che vede che contiamo dice: dovete contare anche i piccoli, centoquaranta per parte. In fondo monti come le Apuane: viti, cotone, sorgo.
Questa visione sarebbe divenuta lo spunto del suo editoriale per il numero speciale del Ponte dedicato alla Cina: cosa c’era di meglio di un ponte ad assurgere a funzione simbolica del dialogo, per agevolare l’invito ad andare oltre la Grande Muraglia? Senza dimenticare il logo della rivista di Calamandrei, in cui su un ponte distrutto dalla guerra un omino attraversa su una passerella, intento ad un’operosa ricostruzione.
Rispondendo al grande scrittore cinese Lao Shi, che aveva accolto la delegazione italiana e inviato una lettera personalmente vergata per il numero speciale, sottolineando la strada della cultura che univa Pechino a Roma, Calamandrei scriveva:
A dieci miglia da Pechino sul fiume Hun Ho la strada passa su un antichissimo ponte monumentale, del quale Marco Polo, che vi passò, ha lasciato una descrizione ammirativa.[…] Per questo si chiama anche oggi il “ponte di Marco Polo”: attraverso quel ponte la cultura cinese e quella italiana possono ancora incontrarsi e comprendersi.
Quella delegazione fu una prima tappa di conoscenza reciproca e di dialogo, sintetizzata nel corposo numero speciale di cui nel 2020 si è pubblicata in Italia un’antologia, rievocandone la genesi (ancora nella rivista Il Ponte). Ora finalmente ne è uscita l’edizione cinese, curata dall’italianista Yang Lin e tradotta dagli studenti dell’Università Nankai di Tianjin. E in copertina c’è ritratto di Calamandrei sul ponte di Marco Polo, quasi a riprenderne il messaggio. (Un ritratto analogo c’è sulla bella pubblicazione fotografica e saggistica della Fondazione Museo storico del Trentino, curata da Silvia Bertolotti, intitolata Sguardi dal ponte, un’altra delle opere che in questi anni hanno ricostruito quel viaggio).
È interessante comparare le due antologie: al pubblico cinese, che deve confrontarsi con periodiche cancellazioni di memorie e documentazioni, le descrizioni della Cina alla metà degli anni cinquanta sono argomento di grande interesse, mentre a noi possono apparire datate ed appaiono più rilevanti le riflessioni di Bobbio e di Calamandrei sulla prima Costituzione cinese ed il ruolo della magistratura, argomenti che invece risultano “sensibili” nella Cina di Xi Jinping, e potrebbero incorrere in censure.
Pur nella differenza, la duplice pubblicazione è un segnale positivo, e personalmente sono grata alla tenacia di Yang Lin e alla disponibilità della professoressa Luo Hongbo, esperta di politica europea, di firmarne la prefazione, nella quale troviamo anche un significativo omaggio a Norberto Bobbio, citandone le traduzioni in cinese. Scrive Luo:
“L’amicizia delle nazioni sta nell’affinità dei popoli, e l’affinità dei popoli sta nell’affinità dei cuori. Gli scambi culturali sono un modo sicuro per raggiungere la comunicazione cuore a cuore, che può consentire a persone di Paesi e regioni diverse di comprendere meglio la storia, i valori, le tradizioni, i costumi e le caratteristiche culturali dell’altro, in modo da eliminare i malintesi e gli stereotipi, e migliorare la comprensione e la fiducia reciproche.
Si può dire che la Delegazione culturale italiana guidata da Calamandrei nel 1955 e il numero speciale del Ponte del 1956, Cina Oggi, sono stati i pionieri nel mettere in pratica questa idea, e il contributo dei membri della Delegazione e di tutti gli autori del numero speciale all’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l’Italia non va trascurato”.
A quasi settant’anni di distanza da quel viaggio esplorativo la duplice attenzione, italiana e cinese, mi pare un ottimo auspicio, e il ponte di Marco Polo ne è l’emblema nella copertina cinese, mentre l’antologia italiana reca il carattere ponte tracciato da un magnifico calligrafo contemporaneo dell’Università di Pechino, Wen Zheng, presidente dell’Associazione per l’insegnamento dell’italiano in Cina.
E non dimentichiamo che il programma di scambi culturali e linguistici tra Italia e Cina prende nome da Marco Polo: gli studenti cinesi che vengono in Italia ad apprendere l’italiano hanno come riferimento un personaggio storico, Marco Polo, ed un personaggio immaginario, Turandot, vista la popolarità universale della nostra opera lirica. Grazie dunque a tutti i traduttori che contribuiscono a fare da ponte tra le due culture, perché la lingua è strumento essenziale di comunicazione.
Chi sa chi tra gli intellettuali cinesi ebbe l’idea di invitare la troupe italiana, un ruolo importante di contatto lo svolse sicuramente il nostro ambasciatore Francisci: la vicenda è ben ricostruita in uno studio di Chiara Lepri. Una vicenda di successo, a differenza di quanto era avvenuto per l’invito ad Antonioni, attribuito agli ambienti attorno a Zhou Enlai; il suo documentario era incorso nelle ire della fazione avversa della Banda dei Quattro, divenendo oggetto di una violenta campagna ideologica.
Ora Marco Polo torna a fare da ponte e chi sa che un domani anche il nostro Matteo Ricci non torni agli onori, se i rapporti diplomatici col Vaticano procedono per il verso giusto. Ad un certo punto tra le immagini di copertina per l’antologia mi era stata proposta la cupola di San Pietro e mi ero chiesta se i rapporti col Vaticano non avessero acquistato preminenza…
La cultura resta comunque un veicolo fondamentale nell’avvicinare i popoli.